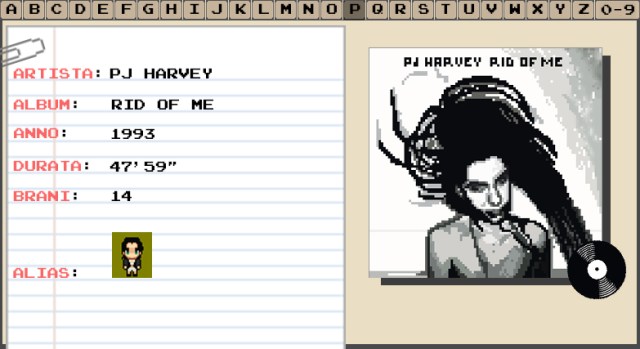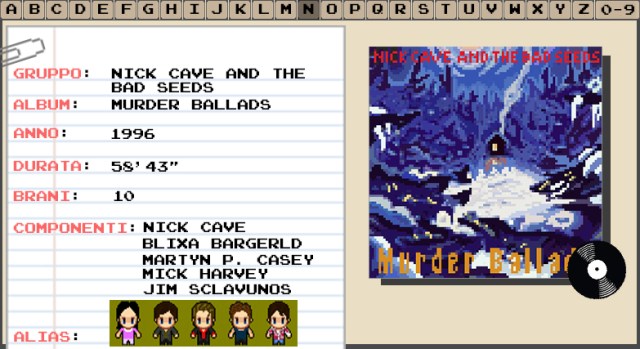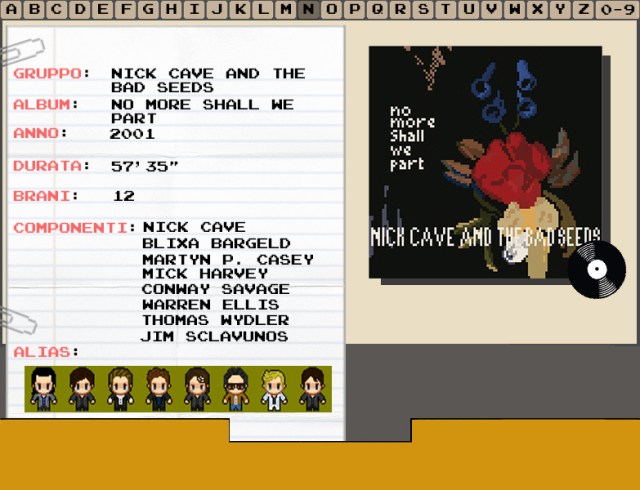Dududu du dududu du dududu du
Papa pa papa pa papa pa pa papa
You’re good- good- good
Penso ai Morphine, a quel giro di basso che arriva dritto allo stomaco, al sax capace di martellare come il volo di un calabrone, al lirismo e al confine tra musica borghese e accessibile. Non posso esimermi dai soliti paragoni, per quanto continuamente Sandman venga posto alla stregua di Tom Waits e Nick Cave esso si esprime con una identità più naturale e genuina, meno teatrale, diretta.
Non è un caso che sia stata una delle band di riferimento degli anni ’90, capace di insinuare nel panorama musicale elementi tipici del jazz e blues con quelli che erano gli strascichi degli anni ’80 basati su new wave e depressione cronica.
Pronti, via, Sandman piazza già la hit di apertura con la title track, il basso a due corde vibra senza sosta, un crescendo che fa vibrare ogni cellula, ed una voce tanto cupa quanto densa. Tutto quanto si sposa da dio con il sax di Dana Colley che entra sempre in punta di piedi intrecciandosi e vestendo i giri di basso con naturalezza. Ne nasce un sound torbido, contraddistinto dalla voce baritona di Sandman, che a tal proposito ha dichiarato: “ Siamo persone baritone e l’effetto cumulativo di tutti questi strumenti genera un sound decisamente grave, ma si riesce comunque a distinguere cosa accade tra gli strumenti. Scatena sul corpo una serie di vibrazioni che piacciono tanto a molte persone”.
Quello che si trova dentro questo album è un tesoro di cui ognuno ha il diritto di usufruire. La suggestione scatenata da Good è quella di trovarsi in un film noir senza tempo, in un pub con il bancone in legno ed una nebbia da fumo degna della Londra autunnale. C’è una rincorsa continua all’amore, l’unicità, le incomprensioni, dichiarazioni surreali, fughe, la capacità di essere parte e di specchiarsi in tutto ciò.
Se dovessi cercare di tracciare una linea dritta per definire quest’album sceglierei questo trittico di canzoni: Good – You Speak My Language – I Know You (part II).
“Something tells me you can read my mind” “Everywhere I go no one understand me, but you speak my language” “Cause you’re just like me and I know you”, sono delle dichiarazioni d’amore esplicite e romantiche che dimostrano quanto questo sia il tema principale dell’album, l’aver trovato qualcuna con cui condividere tutto, senza però apparire melenso o fuori fuoco.
I Morphine, al contrario di quanto si possa pensare, devono il loro nome non alla morfina, quanto a Morfeo, il dio del sonno:
“Ho saputo che c’è una droga che si chiama morfina (morphine), ma non veniamo da lì… noi stavamo dormendo, Morfeo è apparso nei nostri sogni… così ci siamo svegliati e abbiamo cominciato la band… eravamo così avvolti dal messaggio apparso in sogno, che siamo stati costretti a fondare la band.”
Mark Sandman ricalca l’archetipo del bluesman che viene sopraffatto dagli eventi della vita, elevando la sua condizione d’artista ad uno stato di grazia che lo guidano ad una immedesimazione completa in ciò che scrive. La morte prematura di due suoi fratelli e un accoltellamento al petto hanno inciso in maniera probante sulla sua vita, andando a gravare successivamente sulla sua ipertensione arteriosa… ma questa – purtroppo – è un’altra storia.

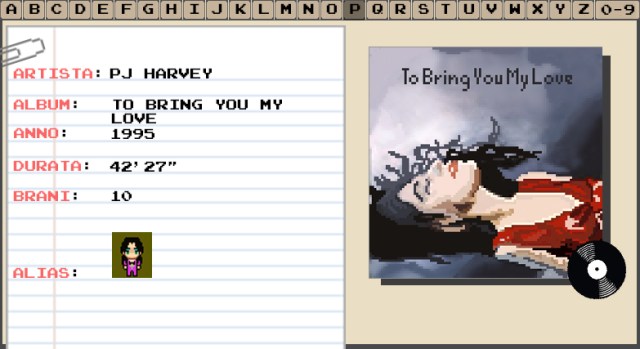 La consacrazione definitiva per PierJulia
La consacrazione definitiva per PierJulia