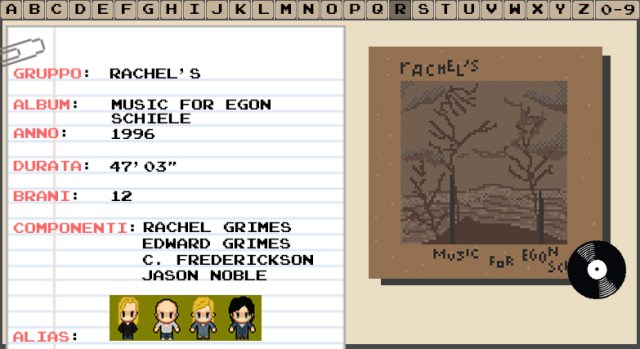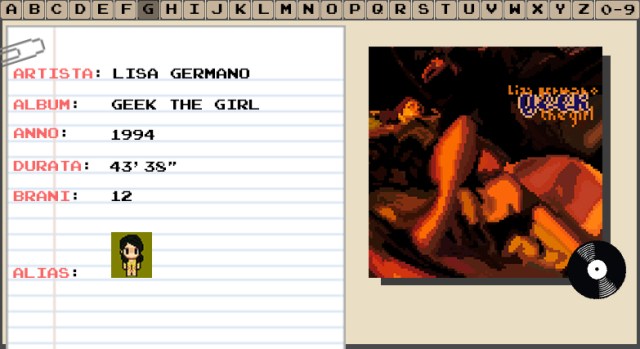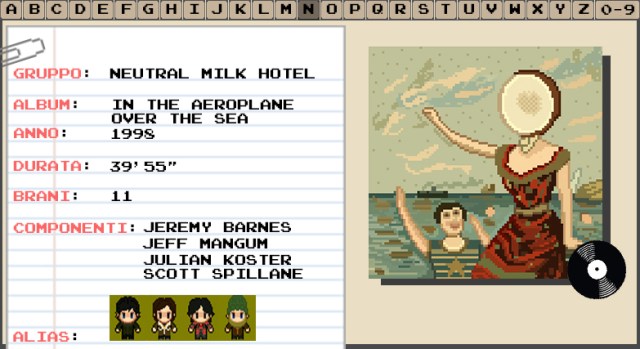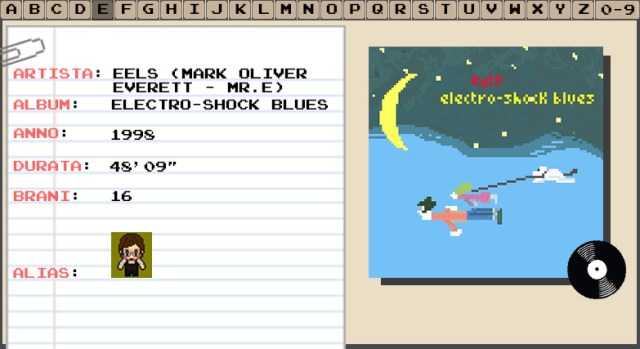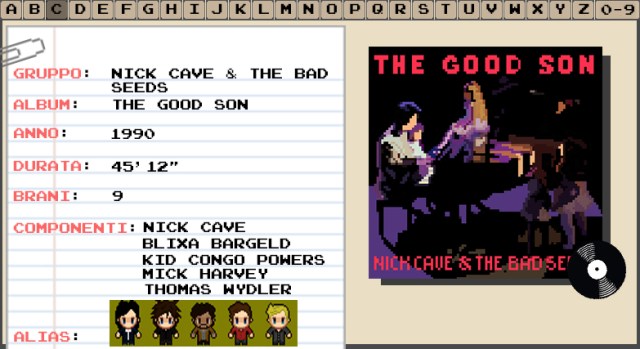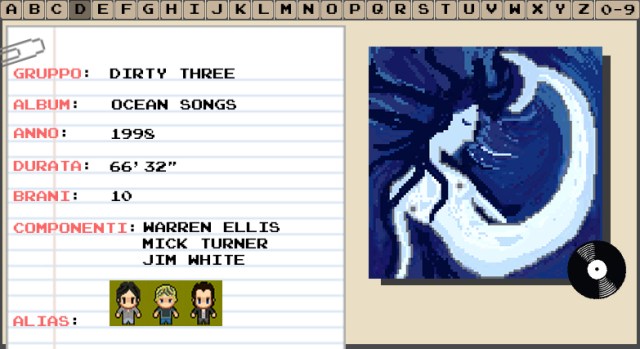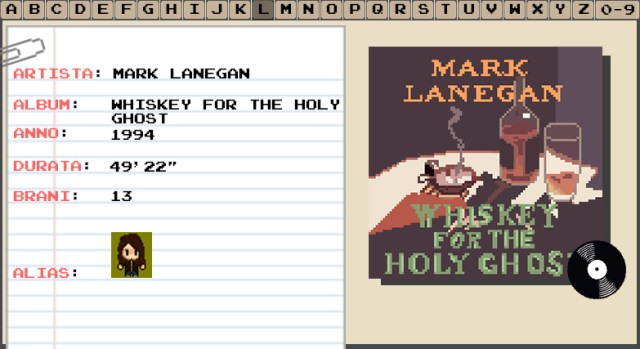Quando penso ai My Bloody Valentine, prima in testa risuona il feedback – così acuto da avere l’impressione di avere delle lame nel cervello – con le distorsioni di chitarra ed i suoni campionati, solo in seconda battuta riesco ad associarli ad una immagine. I suoni dei quali sto parlando provengono tutti da Loveless.
Potrei scrivere di quanto Loveless sia stato un disco epocale, potrei continuare magnificando l’impatto che i My Bloody Valentine hanno avuto sul panorama musicale, (di fatto sto scrivendo tutto questo @_@) ma non lo farò (falso), in quanto questo è ciò che fanno tutti quando di mezzo c’è Loveless (vero).
Quindi in questo articolo – che si sta trasformando ormai in un surrogato di una canzone di Paolo Meneguzzi – è necessario aggiungere un po’ di sostanza, che ne dite? (ve lo ricordate che spettacolo di video trash che aveva buttato su il buon Meneguzzi per l’occasione?)
Per molto tempo, si è pensato ai My Bloody Valentine come degni eredi di Fleetwood Mac e ABBA (falso). La realtà dei fatti però vede questo assunto vero a metà (falso è stato un gioco, falso io lì non c’ero [perdonatemi, interrompo subito la meneguzzite violenta che mi sta ammorbando ndr]), Bilinda Butcher – ragazza madre londinese, nonché chitarrista e meravigliosa voce dei MBV – e Kevin Shields – fondatore dei My Bloody Valentine – hanno una tresca, cosa che fisiologicamente non può esserci tra Colm O’Ciosoig e Debbie Googe, un po’ per colpa del di lui nome, un po’ perché ella convinta militante sgranocchiapassere.
Ma non soffermiamoci troppo sul gossip da due spicci, suvvia!
Dietro Loveless si celano svariate ispirazioni, Bilinda ad esempio spendeva gran parte dei suoi giorni felici ad assistere a concertini di gruppettini come Birthday Party, Joy Division e Talking Heads, ma anche Cramps. Ecco proprio da questi ultimi Kevin ha mutuato lo stile nel suonare la sua Jazzmaster, di ritorno da un loro concerto a Berlino nel 1984 – come un Winston Smith assalito da una sequela di dubbi – si pone la domanda “Ma se suonassi la chitarra tenendo costantemente la mano sul tremolo??? Devo provarci”. E alla fine ci ha provato e si vede che gli è pure piaciuto.
Non mi inoltro nei gusti degli altri per le fonti di ispirazione, perché fondamentalmente sono stati Kevin e Bil i fautori del disco, anzi… diciamo che l’aspetto musicale è stato curato in toto dal buon Kevin che a detta di Bilinda ha sempre avuto il quadro ben chiaro nella propria mente. Talmente chiaro da reputare una perdita di tempo lo spiegare agli altri membri della band le loro parti e come le aveva pensate. È così che Loveless prende forma, con Kevin che suona le parti di tutti durante le 19 sessioni… eh sì, suona le parti di Bil, di Colm e di Debbie; tant’è che quest’ultima durante le sessioni di chiusura riduce drasticamente la presenza negli studi.
A Bilinda questa storia poi non è che abbia fatto più di tanto né caldo né freddo, di fatto è sempre stata come appare, ai limiti del “lascia scorrere”, l’aneddoto sull’origine del suo nome vi darà una dimensione della sua persona “Proviene da mio nonno, se fossi stato un maschietto mi sarei chiamata Bill, ma nascendo femmina divenne Bilinda. John Peel una volta disse durante la propria trasmissione che era solo un tentativo presuntuoso di rendere speciale il mio nome [pensava si chiamasse Belinda ndr]. Mi ha infastidita. È il nome che mi hanno dato… ma non avevo energie per scrivergli un reclamo”.
Bilinda è questa, una ragazza che non consentiva agli ingegneri di presenziare alle registrazioni della propria voce durante le sessioni in studio con Kevin. Capite bene che l’essere guidata in tutto e per tutto da Shields non è stata sicuramente vissuta come un’imposizione.
Certo che essere svegliata all’alba – dopo aver appena abbracciato Morfeo – per ottenere una voce sognante e sonnacchiosa nelle registrazioni, non deve esser stato piacevole “Kevin ha sempre difeso il mito di noi come una band. Nelle interviste non ha mai affermato di essere l’unico a fare musica. Probabilmente si arrabbierebbe se leggesse ciò che sto dicendo ora. Colm aveva buone idee ma considerato che eravamo sempre di fretta durante le registrazioni, Kevin ci chiedeva di non suonare nulla [mhhh, che divertimento ndr]. Andavamo tutti insieme in studio e Kevin ci voleva lì per conoscere le nostre opinioni, non era un dittatore. Le canzoni prendevano forma di volta in volta”.
Riguardo lo scarso contributo di Colm, Kevin mostra una versione dei fatti più dettagliata “Colm aveva raggiunto il limite, era diventato un senzatetto. Veniva ospitato sui divani ma poi si è buscato un virus brutto brutto brutto. La sua salute andava di male in peggio. È stato un periodaccio per tutti noi, troppa pressione”.
I testi invece hanno visto l’intervento decisivo di Bilinda, in confronti serrati e rigorosi a tavolino con Kevin per buttar giù qualcosa che fosse originale, nel tentativo di evitare ogni sorta di potenziale banalità. La sensibilità femminile e la timidezza vocale (soprattutto dal vivo) sono ampiamente percepibili, in una combinazione che rappresenta quello che Bilinda chiama “terapia ipnotica”, così come la piena dedizione e l’ammirazione nei confronti di Kim Gordon dei Sonic Youth, vera stella polare di Bil.
Difficile trovare una descrizione più corretta di “terapia ipnotica” per Loveless [solo per l’aspetto musicale, i video fanno venire il mal di mare e sbattono in faccia una serie di cliché da videomaker anni ‘90 niente male], un disco a cavallo fra la depressione e la redenzione, tra chitarre dissonanti e sensazioni zen, non c’è nulla fuori posto. Unica raccomandazione: lasciarsi trasportare secondo per secondo, senza farsi domande.
Perché gli anni ‘90 – in fondo – sono stati veramente belli.