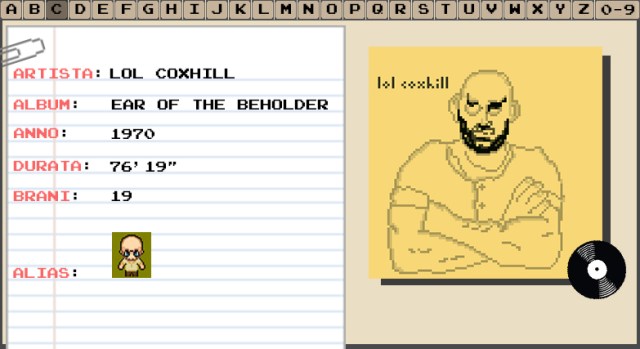
Lo ammetto, con questo disco metto a prova la vostra pazienza.
Se doveste approcciarvi a Ear Of The Beholder ascoltando Hungerford (ovvero la prima traccia che segue l’introduzione) è probabile che io possa ricevere dei vaffanculo tonanti da parte vostra; non esagero. Potreste avere la sensazione di ascoltare un John Zorn pesantemente sotto eroina e buttereste via il disco non appena possibile (mi piace immaginare che qualcuno di voi ancora compri la musica in supporti fisici).
Ok, ok, ok, proseguendo con Deviation Dance la situazione potrebbe non cambiare, andiamo sicuramente su qualcosa di più orecchiabile ma sento la necessità di chiedervi di assettarvi 5 minuti per leggere queste due righe, in modo tale che voi siate preparati ad affrontare questo capolavoro con il quale Lol Coxhill ha esordito come solista.
La domanda che sorge spontanea ai più è “ma chi è Lol Coxhill“?
Ne ho già parlato tempo addietro, ricordate i The Whole World? La band in accompagnamento a Kevin Ayers? In poche parole, è stata una figura di spicco della scena di Canterbury, una sorta di chioccia – data la differenza di età – per i tanti gruppi che sono fioriti in quella città. Il background free jazz è marcato nelle sue composizioni, l’improvvisazione è un obbligo morale che segue senza tregua e segna le sue esibizioni dal vivo, così come il fascino subito da figure come Xenakis, Varese e Stockhausen [offtopic: avete notato come tornano regolarmente a trovarci questi signori? Rispondono presente a quasi tutti i cicli di pubblicazione di Pillole. Diciamo che tutti questi ascolti sono propedeutici per arrivare da loro e John Cage. Vedremo quanto è tortuosa la strada per arrivarci. /offtopic ndr], o da altre band all’epoca contemporanee, come potrete desumere dalla strepitosa cover di I Am The Walrus.
Tutto ciò in favore di una contaminazione di stili e di generi volta ad abbattere il concetto di “genere musicale”, la musica è liquida, attraversa varie fasi e sfaccettature, ingabbiarla all’interno di un genere è “ingeneroso” [perdonate il gioco di parole]. Famoso purtroppo solo nella terra d’Albione e nei Paesi Bassi, non è riuscito ad avere il giusto riconoscimento nel resto del vecchio continente, lasciando comunque ai posteri tante cosette da apprezzare, tra le quali Ear Of Beholder.
Un disco caratterizzato da registrazioni fatte qua e là, in alcuni casi per strada durante le attività da busker di Coxhill per le quali si scuserà con l’ascoltatore per la qualità (un aspetto in comune con Moondog; Lol divenne artista di strada quando lasciò il lavoro di rilegatore di libri), alle registrazioni di alcuni brani prendono parte anche il caro Mike Oldfield, Kirwin Dear e Robert of Dulwich, altri non sono che gli pseudonimi di Kevin Ayers e Robert Wyatt. Ma in particolare spiccano le collaborazioni con David Bedford – anch’egli ex Whole World – con le quali registra delle versioni di Two Little Pidgeons e Don Alfonso (ri-edita da Oldfield qualche anno dopo).
Tutto questo pippone per dirvi di non lasciarvi spaventare dalle composizioni all’apparenza inaccessibili, date una chance di ascolto a quest’album, magari partendo da qualche brano più semplice, giusto per prendere confidenza con Lol e capire che straccia di musicista era.


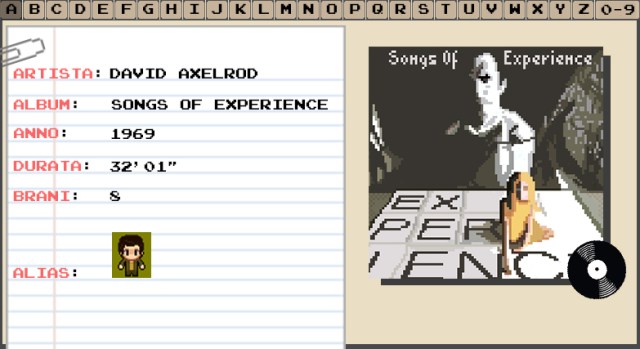


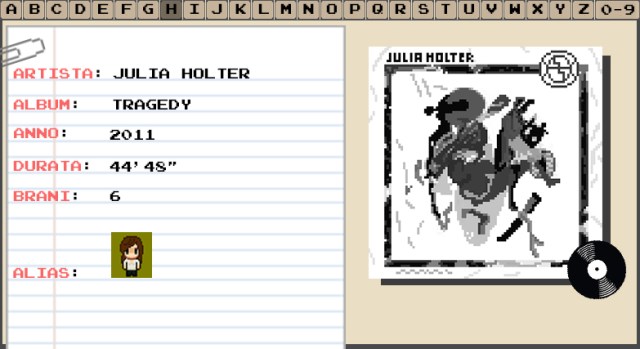

 Mac Demarco è un imbecille.
Mac Demarco è un imbecille.