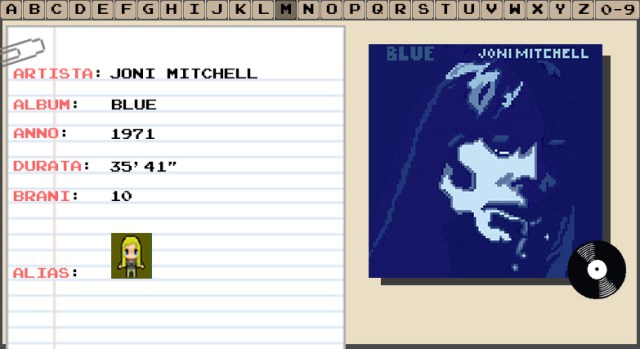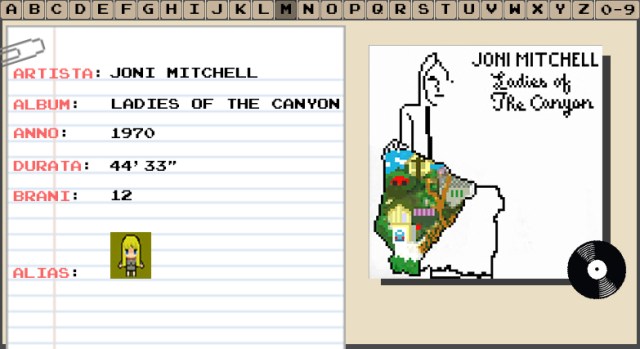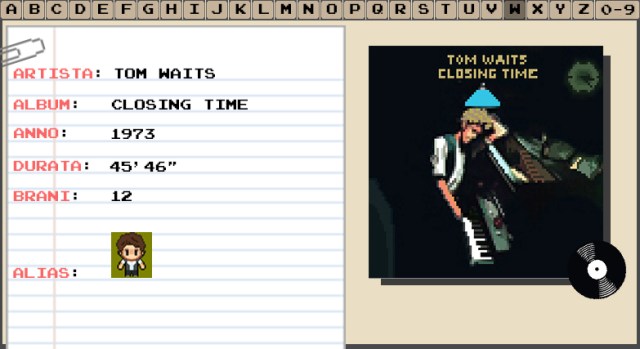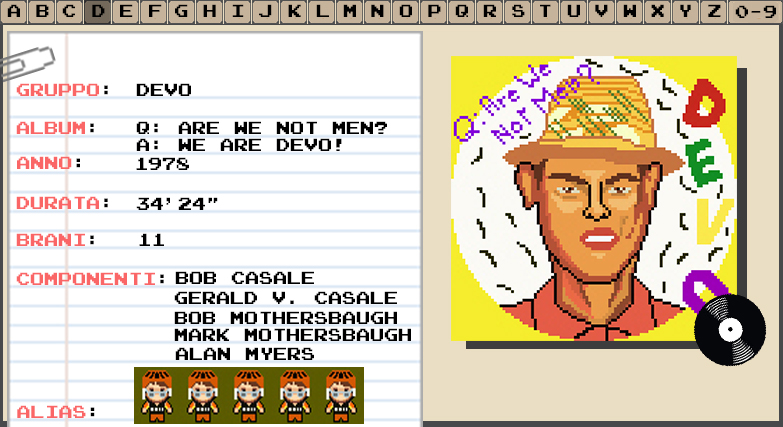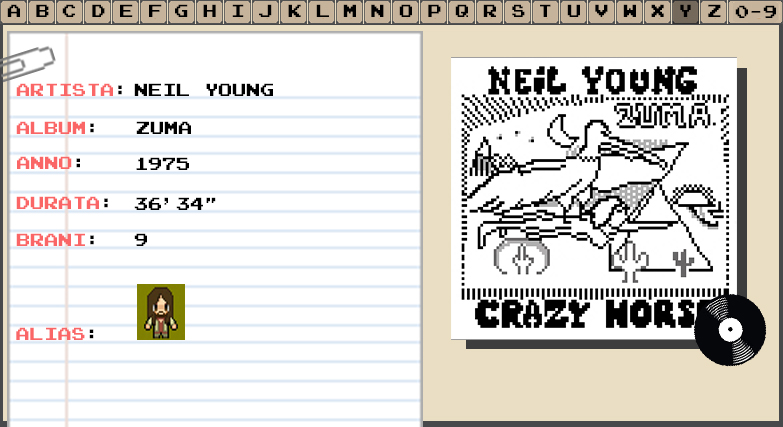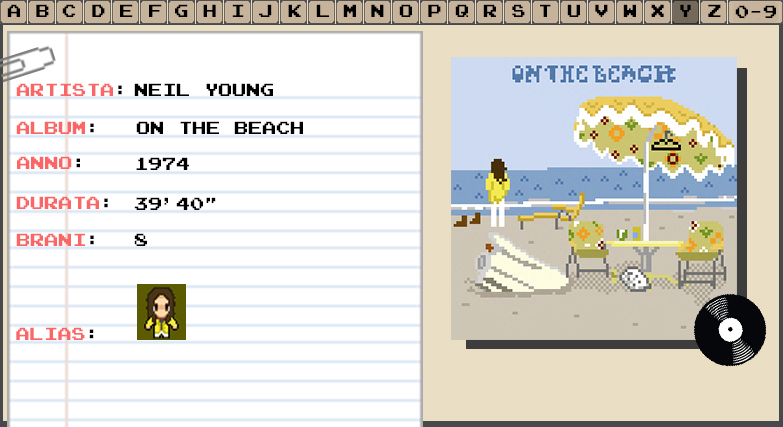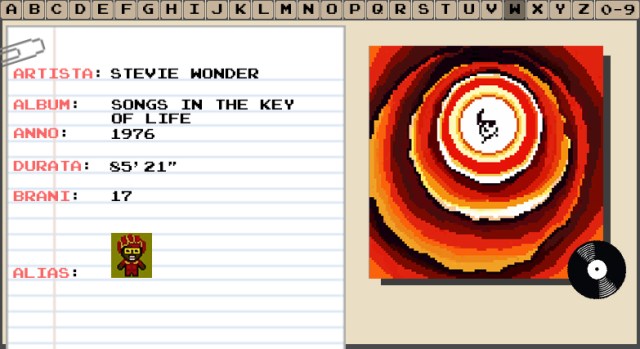 Ci sono dischi che segnano un’epoca, una intera generazione di musicisti e non. Ci sono dischi che restano sospesi nel tempo, segnando uno spartiacque e diventando immortali.
Ci sono dischi che segnano un’epoca, una intera generazione di musicisti e non. Ci sono dischi che restano sospesi nel tempo, segnando uno spartiacque e diventando immortali.
Songs In The Key Of Life ha fatto scuola tanto nella musica leggera, quanto nel soul, nel R&B, nel blues iscrivendo Stevie Wonder nell’olimpo della musica black e non solo, più di quanto i precedenti Talking Book, Innervision, Fulfillingness’ First Finale avessero contribuito a fare.
Come scritto poco sopra, Songs In The Key Of Life ha insegnato a tanti come si fa musica dal 1976 ad oggi – da Michael Jackson a Prince, da George Michael a Whitney Houston – ma al contempo dimostra di essere un sapiente lavoro di taglia e cuci da parte di Stevie che crea un compendio di tutta la musica nera in poco più di 85 minuti, dal soul al R&B, dal jazz fusion al funk, sino al rap.
Un doppio album che parla di relazioni e di amore in due dischi. Dischi che si avvalgono della collaborazione di oltre 130 musicisti, tra i quali spiccano Herbie Hancock e George Benson.
In Songs In The Key Of Life troviamo tante di quelle canzoni che non basterebbe un libro per raccontarle in modo esaustivo, perciò mi limiterò a scrivere di poche sfumature che hanno contribuito a creare la leggenda di questo album.
Come ad esempio Sir Duke, dedicata al compianto Duke Ellington (scomparso nel 1974) con riferimenti ad altri mostri sacri del Jazz:
“There’s Basie, Miller, Satchmo (ndr. Armstrong), and the king of all, Sir Duke (ndr. Ellington)
And with a voice like Ella‘s ringing out (ndr. Fitzgerald)
There’s no way the band can lose.”
La necessità di tributare un brano – per qualcuno di radicale ispirazione – è nella natura di Wonder, che fa lo stesso anche per Bob Marley (con Master Blaster) e Martin Luther King (con Happy Birthday). “Volevo dimostrare apprezzamento verso i musicisti che avevano fatto qualcosa per noi […] perciò sapevo il titolo della canzone sin dall’inizio”, dichiarerà in seguito Wonder.
As – che deve il titolo alla prima parola pronunciata nella canzone – è un altro pezzo da 90 presente in Songs In The Key Of Life e si presta a 3 chiavi di lettura differenti:
1) nel primo caso la canzone viene vista come una dichiarazione d’amore che un uomo rivolge alla propria metà;
2) la seconda è una visione basata sull’amore universale da parte del cantante nei confronti di tutto il creato;
3) la terza è una interpretazione spirituale nella quale vi è un Dio che si rivolge al proprio ascoltatore.
Pastime Paradise continua un po’ nel filone mistico tracciato da As grazie al coro degli Hare Krisna e al sintetizzatore che simula il suono degli archi, in pratica un pastiche di suoni – finto-sofisticati. Questa canzone fornisce – sia per tematiche che per sonorità – un modello al quale gran parte dei rapper si adatterà a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, talvolta scimmiottandolo altre con risultati egregi.
Eppure Songs in The Key Of Life ha rischiato di restare nella mente e nelle mani di Stevie, tant’è che – dopo aver raggiunto lo status di esponente musicale di riferimento della black music – la sua carriera stava per essere congelata, tutto quanto per votarsi al volontariato in Ghana. Il rinnovo contrattuale a tanti zeri con la Motown ha consentito a Mr. Fantastico di proseguire per la sua strada donando a tutti quanti un lavoro estremamente completo.