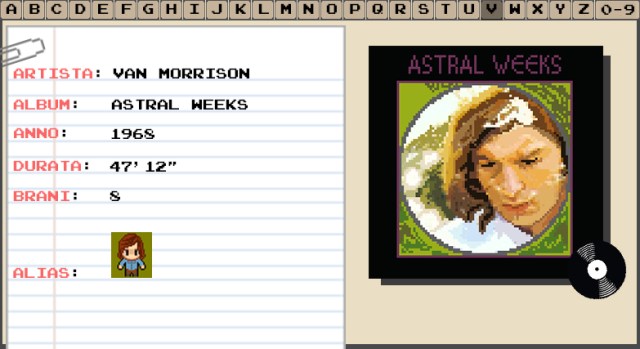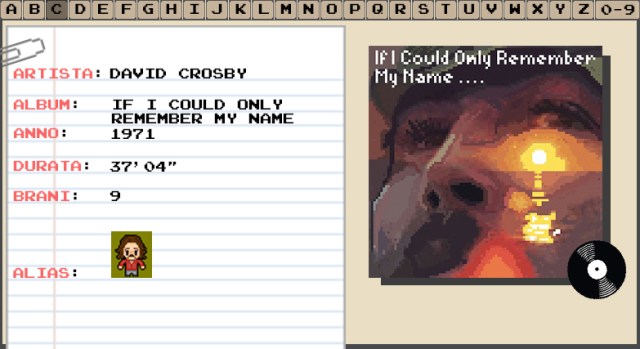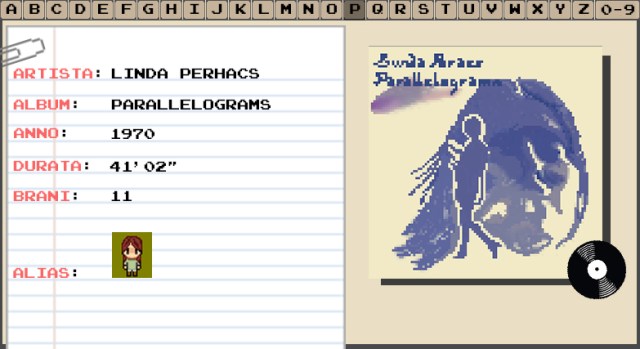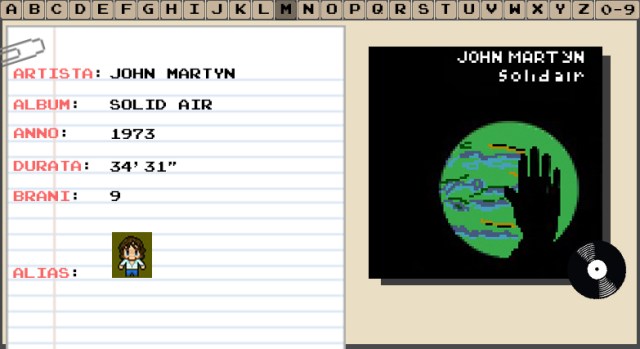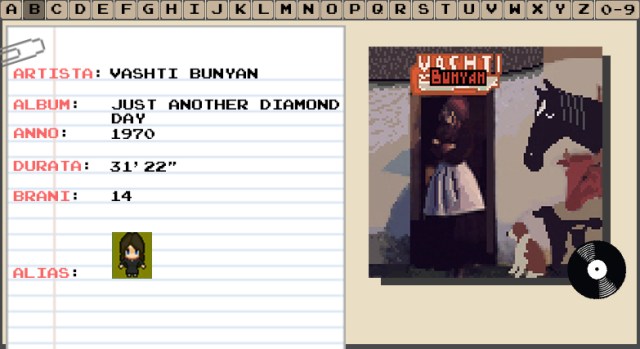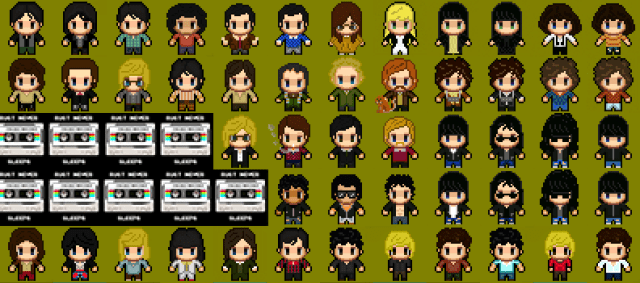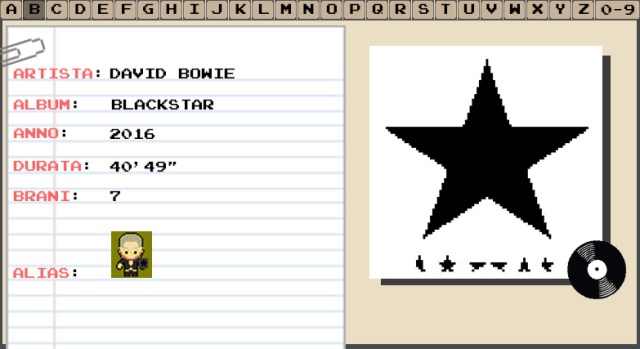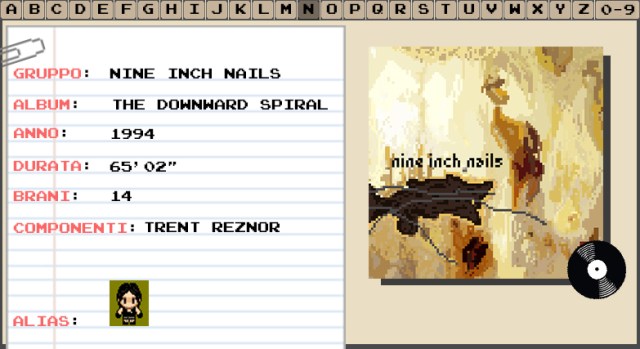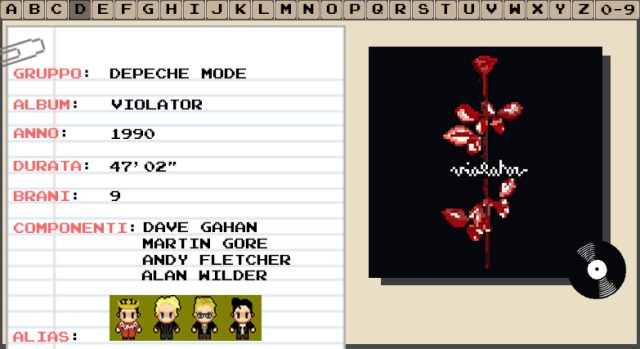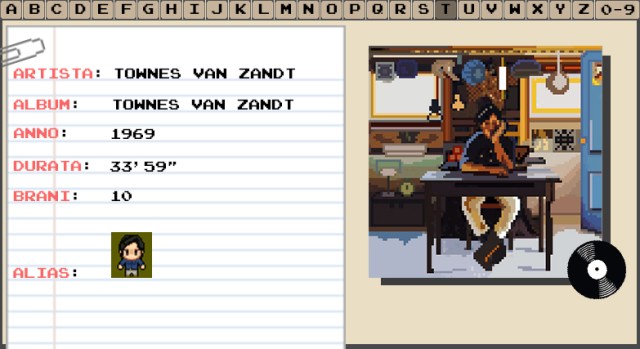
Allora… che cazzo di nome è Townes? Me lo sono sempre chiesto, naturalmente non ho avuto una risposta alla mia domanda, fino a quando ho capito che era un semplice cognome usato a mo’ di nome d’arte. C’è da dire sicuramente che è la prima cosa che mi ha attratto, così strano da sembrare simile a quello di un personaggio letterario di Steinbeck.
Di sicuro Townes ha tutte le carte in regola per rientrare nella cerchia dei bravi ragazzi: cocainomane, alcoolizzato, schivo ed ispirato, oltre che morto, condizione necessaria perché un musicista piaccia alle generazioni di oggi e agli hipster di turno disposti a comprarsi tutta la discografia in comodi vinili da ascoltare in giro.
Oltre a una buona dose di Texas e all’aria resa frizzantina dalla sedia elettrica, ciò che si denota da quest’album è la semplicità, la volontà di raccontare delle storie in maniera schietta, nel più classico del cantautorato, senza scadere nella marmellata di merda che è il Country stereotipato che tanto piace ai redneck. La raffinatezza non viene data dalla pennata e contro-pennata di Townes, bensì da armonie e canzoni che ammiccano al Bob Dylan anni ’60 (come nel capolavoro Fare Thee Whell, Miss Carousel).
L’album in questione racchiude vecchi successi presenti nel primo lavoro dell’artista – agghindati e lustrati a dovere per l’occasione – mescolati con altri brani che riescono nell’intento di non far apparire pesci fuor d’acqua le composizioni passate.
Personalmente la mia attenzione cade su Lungs, come molte delle canzoni di Van Zandt il significato risulta poco chiaro, non tanto nel testo, quanto nell’interpretazione che gli si vuol dare. Lungs viene riconosciuto da molti come un brano autobiografico, l’origine di questa supposizione è ricondotta alla cura contro la schizofrenia al quale fu sottoposto il buon caro John Townes ad inizio anni ’60. La così detta ICT (insulin-coma-therapy) ha creato in lui dei buchi di memoria e una cicatrice che sicuramente lo ha portato a cadere continuamente nel baratro dei vizi sino alla sua fine.
Uno degli effetti principali della ICT – oltre agli spasmi – è la difficoltà nel respirare. Probabilmente Townes, ha provato a descrivere quella sensazione di disagio provata durante le cure, perciò “won’t you lend your lungs to me? Mine are collapsing” risulta essere una richiesta di aiuto, e ancora “Breath I’ll take, breath I’ll give/ Pray the day ain’t poison” è la conferma di quanto la condizione fisica del cantautore fosse provata da una cura distruttiva e screditata col passare degli anni.
Quello che a mio avviso vale la pena sottolineare di questa canzone è quanto inizialmente venga mostrato il deterioramento fisico, quindi con una concezione terrena e oggettiva del mondo per poi crescere mano a mano, in una ricerca del senso dell’universo, della morale con metafore mistiche. “Fill the sky with screams and cries”, si riferisce all’urlo che rimane strozzato in gola al giovane Townes, che tenta di sfogarsi contro la tortura silenziosa del coma indotto.
A tal proposito Lyle Lovett – che assieme a Steve Earle rese omaggio cantando Lungs al concerto tributo – ha detto: “Townes mi disse ‘Questa canzone deve essere urlata, non cantata”.
E’ difficile esprimersi con certezza riguardo l’origine della canzone, ma sicuramente questa è una delle chiavi di lettura interessante e verosimile. Perché soffermarsi su Lungs e non parlare del resto del disco? Perché come per ogni cantautore che si rispetti tutti i brani andrebbero approfonditi, studiati e allora questo sito non si chiamerebbe più Pillole Musicali 8 bit, ma Analisi del testo 8 bit. Lungs è a mio avviso il brano più rappresentativo dell’album per capire chi fosse Townes ed il suo modo di scrivere le canzoni, sapere cosa c’è dietro è molto utile per apprezzare il resto del disco, senza dover utilizzare altre parole.